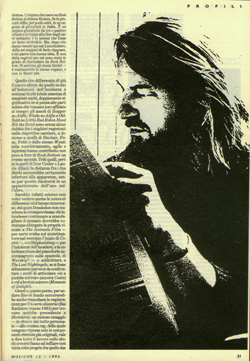| |
|
|
 Robert
Wyatt - Musiche
N°12 - Primavera 1992 Robert
Wyatt - Musiche
N°12 - Primavera 1992
ROBERT WYATT
Mi chiedo spesso di che cosa vivrò nei prossimi dieci anni. Non puoi pretendere che la gente continui ad ascoltarti quando c’è così tanto da sentire. Ma poi incroci le dita sperando che ce ne siano abbastanza da permetterti di pagare le bollette del gas (1).
Dondestan
(Rough Trade 1991, lp e cd)
di Alessandro Achilli
La storia, ormai, dovrebbe esser nota ai più: verso la metà degli anni ottanta Alfreda Benge e Robert Wyatt decidono di svernare in Catalogna, dove Alfreda scrive Out of Season, una serie di poesie sull’esperienza di “vivere fuori stagione in una località di villeggiatura estiva e su come le cose, decontestualizzate, divengano simili a relitti alla deriva”.
Dopo il definitivo ritorno in Inghilterra, per qualche anno Wyatt non compone più canzoni:
“Ho fatto cose come scrivere articoli per il Morning Star su argomenti come la musica folk bulgara, le stazioni radio estere o, nel caso del mio ultimo pezzo, Courtney Pine. Ho anche scritto lettere a chiunque le pubblicasse e a molti che non l’avrebbero fatto. Non molto, no? Sono probabilmente diventato la versione di sinistra di quegli anacronistici generali a riposo che vergano lettere furiose al Daily Express: solo che io scrivo alla Bbc”.
Piano piano, però, le poesie di Alfreda iniziano a far girare per il verso giusto certe rotelline nella mente del musicista (“quando qualcosa ti è molto familiare, diventa quasi come una canzone nella tua testa. Non posso dire che sia una regola ma è questo che è accaduto”), che per la prima volta nella sua carriera viene tentato dall’idea di comporre musica su testi preesistenti. La partecipazione (insieme a Evan Parker, Roswell Rudd, Derek Bailey e altri) a un progetto (mai pubblicato) di Kip Hanrahan incentrato su poesie di Paul Haines lo fa riflettere una volta di più su quanto possa essere stimolante lavorare su testi altrui, soprattutto se non si considera lo scrivere canzoni come il proprio mestiere:
“Ho cominciato come batterista, e poi sono diventato solo un cantante, perché era l’unica cosa che potessi fare bene una volta ritrovatomi su una sedia a rotelle. Non sono mai stato un autore di canzoni nel senso di occuparmene a tempo pieno. Quando ho abbastanza idee, comincio a lavorarci sopra. Ci dev’essere una ragione per ogni disco che faccio”.
E la ragione per Dondestan è proprio Out of Season:
“Improvvisamente l’impresa cessò di somigliare alla scalata di una montagna. La musica iniziò a prendere forma nella mia testa.
Così ho cantato una mezza dozzina delle sue poesie e ho scritto appositamente alcune delle mie solite robe soltanto per il finale”.
Non resta che trovare uno studio di registrazione e The Chapel, poco distante da casa, sembra adatto all’uopo: “Han montato rampe in modo che potessi arrivare ovunque e di fatto sono vissuto là per due settimane. C’era anche un cuoco che mi preparava i miei pasti vegetariani”. È lì che Wyatt registra il disco, suonando lui stesso (come anche negli ultimi lavori) tutti gli strumenti, compresi alcuni elementi di batteria che già avevano fatto la loro apparizione su Chairman Mao e su alcuni brani di Old Rottenhat, anche se soltanto ora si sente finalmente la gioia ritrovata di giocare con le bacchette su pelli e metalli:
“Adesso uso solamente la parte superiore del kit. Soltanto un paio di timbales e i piatti. Per anni ho pensato che non ci sarei riuscito, perché mi era sempre piaciuto usare charleston e cassa, ma poi mi sono ritrovato a suonare a casa ascoltando dischi di jazz e mi sono accorto che potevo farcela.
Be’, c’è voluto un bel po’ per trovarmi a mio agio con l’idea di essere io stesso un gruppo e ad accettare il fatto di non essere più un vero batterista. Ora ho imparato ad apprezzare la parte superiore del kit, e a elaborare linee di basso, e anche un metodo per suonarle io stesso, in modo che le canzoni mi risultino complete e coerenti. Il mio problema era solo che quella parte dello scrivere canzoni relativa alle parole non veniva oliata da un po’, dato che scrivere lettere o chiacchierare è del tutto differente da scrivere testi che dovranno essere ascoltati più volte”.
|

|
Come è stato rilevato da più parti, Dondestan è forse quello fra i lavori dell’artista che più si avvicina a Rock Bottom, il disco che, diciassette anni fa, fu unanimemente salutato come un capolavoro e che tutt’oggi è opinione diffusa ritenere la vetta insuperata dell’opera wyattiana. Una valutazione, quest’ultima, che deve certamente qualcosa alla prassi nostalgica di considerare come la migliore di un artista l’opera attraverso la quale lo si è scoperto e di rimpiangere con essa la propria giovinezza. Nondimeno, Rock Bottom seppe riunire e rappresentare egregiamente i tratti salienti della miglior vena compositiva dell’autore (così come la si era conosciuta con le prime canzoni per i Soft Machine, culminate nell’indicibile Moon in June, e poi nei lavori in proprio e con i Matching Mole), e allo stesso tempo costituì una prefigurazione di quanto avrebbe saputo offrire lo Wyatt a venire.
Motivi storici e affettivi, dunque, congiurano in molti ascoltatori nel non accettare il paragone fra i due dischi. Se si deve dar retta alle proprie orecchie, però, il primo approccio con Dondestan è fulminante: impossibile non sentire che i primi tre brani sono fatti della stessa pasta delle antiche Sea Song, Last Straw, Alifie e Alifib; dell’ultima, in particolare, The Sight of the Wind (un brano “sull’ineffabilità delle cose”) riprende anche l’idea del ritmo tenuto da inspirazioni-espirazioni, usandola per eludere una scansione troppo marcata del sette quarti. L’accostamento al disco del ’74 (in ogni caso tutt’altro che negato dall’autore) è dato soprattutto dall’atmosfera che si respira, dal passo di questi brani e da vari elementi sparsi (l’incipit – organo, pianoforte e piatti – di Catholic Architecture, quello di Lisp Service, con quel modo di piegare la voce e quella melodia) ma non è da sottovalutare la componente timbrica, dove fra le stratificazioni di tastiere affiora spesso (Costa, The Sight of The Wind, Left on Man…) quell’organo che tanta voce in capitolo ebbe allora:
“Sono entrato in Dondestan più che in qualsiasi altra cosa dopo Rock Bottom. L’organo che usavo su Rock Bottom si chiama Riviera. Se lo procurò Alfie, per pochi soldi, in un negozio di giocattoli in Italia. È un organo giocattolo da tre o quattro ottave e si ruppe alla fine degli anni settanta, e io pensai che fosse un fatto simbolico. Ma, dopo che siamo venuti qui nel Lincolnshire, Alfie mi suggerì di farlo riparare e mi parve una buona idea. È una delle ragioni per cui sono stato in grado di riprendere da Rock Bottom. Si sentono gli stessi timbri: è esattamente lo stesso organo, e non lo fanno più”.
Ciò che differenzia di più il nuovo album da quello inciso all’indomani dell’incidente è semmai la più totale assenza di musicisti ospiti, doppiamente significativa se si pensa alle parti solistiche che furono loro affidate al tempo: gli assoli di Hopper su Alifib, Windo su Alifie e Oldfield su Little Red Robin Hood Hit The Road sono senza alcun dubbio fra i migliori registrati nelle rispettive carriere, e insieme a quelli di Sinclair, Feza, Frith e dello stesso Wyatt (alla voce-strumento, agile e ispirata) hanno contribuito non poco a fare di Rock Bottom un evento epocale. Tolti quelli, però (e le parti di Ivor Cutler o Laurie Allan), la distanza tra i due dischi suonerebbe certamente inferiore alle apparenze, senza per questo risolversi in un appiattimento dell’uno sull’altro.
Sarebbe infatti sciocco non voler vedere anche le notevoli differenze e il tempo intercorso, del quale Dondestan non maschera la consapevolezza: chi intendesse continuare a scandagliare il passato dovrebbe comunque allargare la propria visuale a The Animals Film – per certe scelte sul sintetizzatore (per esempio l’inizio di Costa) –, o a Shipbuilding – per l’indolenza dell’incedere, e le coloriture blues del pianoforte accompagnato sulle spazzole, di Worship (2) – o addirittura a The Last Nightingale, se si fosse abbastanza perversi da confrontare i modi di articolare “in a puddle mirror” (ancora Costa) e “of a broken mirror” (Moments of Delight).
|
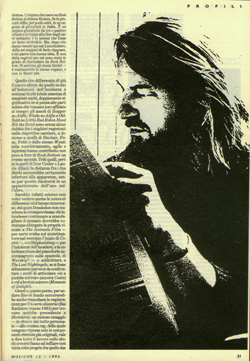
|
Giunti a questo punto, per andare fino in fondo occorrerebbe anche riascoltare le registrazioni per Un certo discorso (Rai Radio3, marzo 1981) per trovare qualche precedente a Shrinkrap, un curioso omaggio – in chiave del tutto personale – alla musica rap, della quale vengono riprese solo le componenti ritenute più originali, vale a dire tutto il lavoro sullo studio (“come fanno a infilare così tanta roba proprio fra quelle due battute? Roba da non credersi!”) e le modalità del cantato-recitato (“quando si parla, le parole sono musica atonale; e la batteria è prevalentemente atonale; il rap è molto liberatorio, lavora solo su ritmi e rime: ecco dov’è la musica, non nelle note”), a discapito di altre, considerate molto più convenzionali (come per esempio le linee di basso). L’orchestrazione di Shrinkrap fa caso a sé: dove gli altri brani sono giocati soprattutto sulla giustapposizione di sintetizzatore, organo e pianoforte – punteggiata dal basso (campionato) e dalla “batteria” e asservita alle evoluzioni del cantato –, qui troviamo una serie di espedienti di studio (per esempio il piatto e il tom con spazzole registrati al contrario), un set più consistente di percussioni e l’uso di “voci” di batteria elettronica suonate in tempo reale; il ritmo (testardo) più che quello del rap ricorda, anche timbricamente, certi ostinati del primigenio The End of An Ear, non a caso uno dei dischi dove il morbido macchinista scavò più a fondo nelle risorse dello studio.
Perché si ritorni al passo dei ricordi iniziali è però sufficiente che rientri l’organo ad annunciare Cp Jeebies, sarcasticamente dedicata al partito comunista inglese (Communist Party of Great Britain, cioè Cpgb), verso la cui attuale politica Wyatt si è dichiarato molto critico, nonostante (o proprio per) la lunga militanza fra quelle file, segnata da una concezione del rapporto con la propria attività artistica che ricorda da vicino quella che fu di un altro grande compositore comunista, Cornelius Cardew:
“Volevo restare fedele alla linea del partito e vedere cosa potevo cavarne fuori. Volevo lavorare più come un membro del partito cui capita di cantare, che come un musicista che trascina la politica dentro la musica. Allo stesso tempo, giunsi alla conclusione che era sempre più difficile prendere sul serio il rock come cultura alternativa e minaccia al vecchio ordine”.
Cp Jeebies dà il via alla parte del disco di cui Wyatt ha scritto anche i testi, esplicitamente politici – come è nel suo stile – ma pregni della modestia di chi non è interessato a far credere di poter mobilitare Grandi Masse per Giuste Cause: “Penso che l’artista abbia, assai più modestamente, il ruolo di testimone: cerco soltanto di fare un notiziario migliore di quelli che continuano a sodomizzare la mia radio!”
Left on Man e Lisp Service parlano di colonialismo:
“C’è colonialismo a go go. Tutto il dibattito politico era incentrato su Est contro Ovest, ma ho sempre pensato che la vera spaccatura fosse fra Nord e Sud, vale a dire lo sfruttamento dei paesi sottosviluppati da parte di quelli industrializzati. E ho trovato proprio deprimente il bombardamento della strada di Bassora durante la guerra del Golfo – quando si stavano ritirando – e tutta l’euforia che l’ha circondato”.
Il cantato di Left on Man è quello che più si avvicina alle venature jazzistiche che assumeva su Old Rottenhat), qui chiamate a mostrare le stimmate lasciate dall’amore per Billie Holiday mentre un coretto – à la Marvin Gaye, secondo alcuni – mette alla berlina i classici modi di non rispondere (“simplify, reduce, oversimplify”) a ciò che l’antimperialismo del testo asserisce:
“Marvin Gaye è molto vicino al mio cuore. C’è qualcosa di trasparente nelle sue tessiture, è come un mare con vari strati e cose dette sottovoce. Ma in realtà l’ispirazione principale è stata quella del gruppo Irakere. Hanno questa cosa cubana dove un paio dei tipi mettono giù gli strumenti e fanno una cosa in coro. Ho pensato: “Mi piace così tanto quando lo fanno loro; perché non essere io il gruppo? Non posso forse mettere giù le mie trombe e tromboni e fare lo stesso?”.
Lisp Service, invece, è l’unico episodio in cui il processo di scrittura è avvenuto in senso inverso, mostrandoci uno Wyatt paroliere alle prese con una partitura di Hugh Hopper. Un’esperienza analoga aveva già dato frutti eccellenti in tempi non lontani (Amber and the Amberines), per non parlare di tutte le perle softmachiniane firmate dal binomio a partire da Memories (giacché delle precedenti non si conoscono tracce registrate). Il livello di quest’ultima collaborazione non è assolutamente da meno, collocandosi anzi fra i punti più emozionanti dell’album, a dispetto del fatto che la partecipazione del baffuto bassista si sia limitata alla composizione della musica (il basso che si sente è chiaramente riprodotto da una tastiera). Il testo è nato come risposta a un video di Billy Joel, che commentava le immagini di tremendi massacri di cui si sono macchiati gli Stati Uniti nel corso di svariate guerre con l’allegro ritornello “We didn’t start the fire / It’s been burning since the world began”:
“We Didn’t Start the Fire mi tormentava. Ho pensato: “Ehi tu, insulso stronzetto! L’avete proprio aperto voi quel cazzo di fuoco! Se dici ‘noi’, posso rivolgermi a te come ‘voi’”. Non ascolto spesso le parole, ma lui stava dicendo “ascoltami, ho qualcosa di serio da dirti”, e io ho pensato “faresti meglio ad avercelo”.
|

|
La voce attacca, quasi infastidita, con la calma dolente di chi vuole trattenersi, ma non può mascherare con la ragionevolezza una rabbia sgomenta e sale solenne, moltiplicata dalla registrazione, per sottolineare i passaggi più duri, le accuse più dirette e vibranti:
“Saccheggi, omicidi, / incursioni da costa a costa, / cari vecchi giorni di sangue, / e ora mi dite / che dovrei imparare a trattare con tutti voi / inchinarmi a voi e lodare gli Dei per / tutto ciò, tutto ciò / che avete vinto per noi. / Dopo tutto quello che era successo prima, / non c’è stata nessuna amnesty / international, / nessuno che vi controllasse”.
È raro scoprirsi così profondamente toccati da due soli minuti di musica e parole ed è singolare scoprire a ogni ascolto quante nuove ed emozionanti sfumature siano racchiuse in tanta semplicità.
Le note conclusive sono quelle di New Information Order / Dondestan, proposte senza soluzione di continuità: la prima punta con desolatezza l’indice verso la privatizzazione dilagante e lascia che sull’accordo finale della tastiera salga il ritmo gioioso e incalzante della seconda che, aguzzando l’orecchio verso gorgheggi kurdi e ritmi uzbeki, dice come in una filastrocca del diritto alla terra di Kurdi e Palestinesi. Prima che il ritmo veloce venga sopraffatto da un cupo accordo tastieristico – misteriosamente imparentato con i luoghi d’acqua di Twin Peaks – si inseriscono in ruolo solistico le percusioni, che danzano su una giostra di sincopi, rullate e controtempi con l’esuberanza di chi abbia atteso fin dal primo momento l’occasione per uscire allo scoperto (come di fatto aveva già lasciato eloquentemente intendere l’iniziale Costa).
O, forse, era un’attesa che durava già da molto, molto prima…
Alessandro Achilli
Note:
1. Questa e tutte le citazioni che seguono sono estrapolate e tradotte da interviste apparse fra settembre e ottobre sulle riviste Spin, Q e The Wire. Tali interviste, per inciso, paiono stranamente simili a quelle apparse più recentemente sulla stampa specializzata italiana – peraltro adusa a spacciare come conversazioni “uniche”, “originali” ed “esclusive” appunti da conferenze stampa o addirittura raffazzonate traduzioni da riviste estere (con i classici actually che diventa “attualmente”, release scambiato per realize e così via), non peggiori, comunque, di quelle riservate alle interviste di prima mano (indicativi al posto di congiuntivi, “poemi” per poesie, “cimbali” per piatti, “facilità” per attrezzature o mezzi o servizi, “socialismo realista” invece che realismo socialista, Paul Haines trasformato in “Paul Heinz”, Kip Hanrahan in “Skip Hanraham”, parole o addirittura intere frasi lasciate in inglese – non sempre corretto: le fanny songs non saranno per caso funny songs? – ecc. ecc. ecc….).
2. Shipbuilding fu proposta a Wyatt (spedendogli una cassetta per posta) nella convinzione che sembrasse una sua canzone: con un paradosso temporale si potrebbe dire che era proprio questa la canzone a cui si riferivano.
|